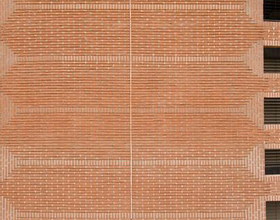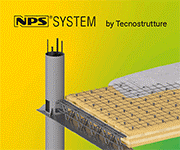NUOVO POLO UNIVERSITARIO DI COMO
-
Obiettivo del progetto era unire i momenti della ricerca universitaria con quelli della didattica, costruendo al contempo un nuovo territorio di relazioni aperte.
L’edificio è definito da uno schema a pianta centrale con gli spazi didattici disposti ad emiciclo e affacciati direttamente sul corpo dei dipartimenti e degli spazi di ricerca. La configurazione del nuovo complesso si lega all’insieme degli elementi che caratterizzano questo particolare contesto contiguo fisicamente alla città murata.
La figura del nuovo edificio si caratterizza quindi sia per le relazioni che esso instaura con i fabbricati del Setificio, nei quali sono ospitate parte delle funzioni didattiche e direzionali dell’Università, sia verso l’esterno con lo spazio a verde pubblico, con la cortina stradale di edilizia residenziale, con le pendici della collina. Obiettivo del progetto era definire un’organizzazione spaziale chiara che consentisse di cogliere unitariamente le relazioni fra le diverse parti, favorendo un orientamento immediato in ogni punto dell’edificio. L’impianto è in parte definito dal rapporto esistente fra una parte più didattica, che si sviluppa su un tracciato circolare, e la parte degli ambiti di ricerca disposta in due corpi di fabbrica convergenti nella zona centrale dell’emiciclo, dove sono collocati gli elementi di distribuzione verticali. Gli spazi distributivi comuni sono illuminati zenitalmente. Complessivamente gli spazi che compongono l’edificio risultano così articolati: tre aule da 200 posti; un’aula magna; quattro aule da 100 posti, una biblioteca con sala lettura; laboratori e spazi docenti.
Crediti fotografici: Emilio Pizzi Team Architects
2855 Realizzazioni