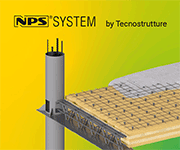ATTUALITÀ
Una conversazione con lo studio di Richard Rogers
Modulo: Ricordo la prima intervista a Richard Rogers nel 1992 e di avergli chiesto perché l’High-Tech sten-tasse ad essere accettato dall’Establishment, visto che i suoi Maestri erano tutti inglesi e con studio a Londra. La risposta fu che la cultura nazionale si riconosceva ancora negli ideali della Tradizione. Dopo quasi venti anni, ritiene che qualcosa sia cambiata nella mentalità e nella cultura della classe dirigente?
Ivan Harbour (partner di Richard Rogers): Il Centro Pompidou ed il Lloyd’s sono due manifesti dell’avanguardia che hanno trasformato il modo di fare architettura. La loro forza innovatrice ha però anche scioccato una certa parte di quella critica conservatrice che non ne condivideva né gli obbiet¬tivi nè i risultati. Per molti anni, lo stesso Movimento Moderno è stato giudicato con sospetto, fino quasi a rifiutarne le conquiste ideologiche. Gli anni ’90 sono stati anni difficili sia da un punto di vista economico che culturale. La recessione si è unita al primato culturale di un Establishment forte di un Governo Conservatore. Dal 1996, i Laburisti, guidati da Tony Blair, hanno consentito un dibattito che ha portato ad un rinnovamento. Così, durante l’amministrazione di Ken Livingston è stato possibile istituire una Urban Task Force, diretta da Rogers, che ha cominciato a sensibilizzare la politica e la gente comune su quanto l’architettura possa incidere sulla qualità urbana e, quindi, sulla qualità della vita di tutti.
Lo studio si è fortemente impegnato a promulgare l’etica della Modernità, aldilà della sua estetica. In questo senso, termini come High-Tech sono in effetti stati negativi perché comunicavano un’esasperazio-ne di certi aspetti del processo costruttivo che erano solo dei “mezzi”, il “fine” è sempre stata la qualità del vivere comune. Ma ci sono voluti anni di conferenze, mostre e pubblicazioni per arrivare oggi ad un clima culturale certamente più aperto e sensibile al valore dell’innovazione.
Nonostante questo, va ricordato che il 70% del nostro lavoro attuale è in corso di realizzazione fuori dai confini britannici.
Modulo: E’ passata una generazione dalla fonda¬zione dello studio, cosa è cambiato nella cultura del progetto e nella ricerca verso l’innovazione dagli anni ’70 ad oggi?
Ivan Harbour: Lo studio ha mantenuto una grande coerenza e continuità di pensiero. Concetti come onestà strutturale, leggibilità del processo costrutti¬vo, flessibilità, leggerezza, assemblaggio a secco dei componenti rimangono alla base del nostro linguaggio. Direi che quello che oggi è cambiato è la tipologia di edifici che affrontiamo. Abbiamo una gamma di complessi in corso che spaziano dai masterplan, agli uffici, ai centri culturali, fino alla residenza, alla scuola ed alla sanità. Siamo cioè in grado di dimostrare il valore civico dei nostri ideali.
Un esempio è Mossbourne Community Academy, la scuola che abbiamo realizzato nel borough di Hackney a Londra che il “Department for Education and Skills” ha giudicato come un modello da seguire per i prossi¬mi programmi didattici. In sanità, il Maggie’s Centre a Londra, è un edificio a piccola scala (170 m2) ma con grande attenzione ai dettagli ed alle finiture. Un piccolo edificio con un grande impatto umano che ha ricevuto lo Stirling Prize nel 2009. Questa trasversalità tipologica e la capacità di progettare dalla piccola alla grande scala caratterizza questo ultimo decennio; gli ideali del nostro studio non sono mai cambiati.
Modulo: Dal Pompidou ad oggi, quali sono state le più grandi conquiste dello studio?
Ivan Harbour: Molte sono state le sfide, ma quella che forse oggi è la più grande conquista è l’essere riusciti a consolidare uno spirito di squadra che ritengo sia la forza vincente dello studio. Il concetto di team work, cioè di massimo spirito collaborativo sono fondamentali per chi vuole lavorare con noi. Ogni lunedì, tutti i diver¬si gruppi che lavorano ad un progetto si riuniscono, dal capo progetto allo stagista, affinché vi sia condi¬visione delle tematiche da affrontare. Nessuno deve sentirsi un esecutore, ma partecipe di quello che sta facendo. Si discute di un progetto con lo spirito di un workshop, cioè con l’intento di sollevare i problemi più che di risolverli. Ci piace l’idea di celebrare la volontà di essere una comunità con la disponibilità verso le opi¬nioni altrui. Uno spirito comunitario che dimostriamo anche nel continuare ad essere una “charity”, cioè a devolvere il 20% del nostro fatturato in beneficenza.
Modulo: Gli studi internazionali più importanti stanno tutti affrontando il loro ‘passaggio generazionale’. Cambiare il nome dello studio da RRP a RSH+P è un evidente segno in questa direzione. Come state affrontando questo canbiamento?
Ivan Harbour: Ci sono molti modi di gestire il così detto passaggio generazionale. Norman Foster è oggi il consulente esterno del suo stesso studio, Nicholas Grimshaw ha scelto di diventarne il chairman. Richard Rogers passa la maggior parte della sua vita in studio e, come sempre, rimane pienamente protagonista di tutte le attività dello studio, ma è arrivato il momento in cui si è sentito il bisogno di “condividere il peso” della gestione delle responsabilità.
Sia Graham Stirk che io svolgiamo, a tutti gli effetti, lo stesso lavoro di prima, solo con maggior consapevolezza. D’altro canto, in termini di età, oggi io sono più giovane rispetto a quando Richard fondò lo studio e quindi vedo un futuro molto lontano, in cui evolvere e cambiare ancora.
Modulo: Da quando i Partners fondatori hanno lasciato il loro ruolo ufficiale, come si è riorganizzato lo studio?
Ivan Harbour: Ai tempi del Pompidou lo studio era composto da poco più di 30 persone, ora siamo oltre 180 nelle varie sedi internazionali. Questo ha richie¬sto un maggior numero di Direttori e responsabili dei vari settori, dall’amministrazione, alla progettazione, affinché non venga mai a mancare il controllo puntuale su ogni lavoro.
Modulo: Se dovesse “nominare” i progetti più simbolici del Terzo Millennio, quali menzionerebbe e perchè?
Ivan Harbour: L’aeroporto di Barajas a Madrid ed il Maggie’s Centre a Londra. Penso che per motivi diversi costituiscano due simboliche innovazioni. Barajas è stata un’esperienza unica che ha aggiornato molti temi identificativi della nostra architettura. Ad esempio l’utilizzo del colore che coadiuva la leggibilità della struttura dei componenti. A Madrid non è stato faci¬le, perché spesso le scelte cromatiche sono legate a connotazioni politiche. Per evitare messaggi di questo genere abbiamo quindi adottato una policromia che enfatizza esclusivamente il valore della composizione. La copertura è un incredibile virtuosismo tecnologico che utilizza il bambù, mai considerato prima per un aeroporto. Il Maggie è un grande successo perché ha dimostrato la capacità dello studio di gestire edifici di piccola scala ma, soprattutto, di saper dialogare con una committenza che non è di tipo aziendale. Siamo cioè riusciti ad interpretare i bisogni di una comunità eterogenea di persone che condividono una missione di solidarietà verso chi soffre.
Modulo: I committenti sembrano essere sempre più cauti con gli investimenti. Cosa si aspettano oggi che forse non chiedevano in passato?
Ivan Harbour: La crisi dei mercati e l’affermarsi delle economie competitive dei paesi emergenti ha avuto anche ricadute positive. Mi riferisco alla maggiore consapevolezza sul valore della qualità. Oggi la qualità dell’architettura si riflette sull’immagine corporativa dell’azienda molto più che in passato. Questo significa anche che la sostenibilità, intesa come benessere interno per gli utenti e riduzione dei costi di gestione, hanno un peso che non avevano in passato. Si è cioè indubbiamente consolidata una presa di coscienza verso un rispetto ed una salvaguardia per l’ambiente che non esisteva prima. In questa direzione, un edificio modello di questo cambiamento è la National Assem¬bly for Wales, anche se forse tutte le potenzialità di questo progetto non sono sfruttate a pieno.
Modulo: Lo studio opera a livello globale ed, oggi, sempre più in Europa: come si colloca la situazione Italiana nello scenario economico e culturale Europeo?
Ivan Harbour: E’ difficile rispondere a questa doman¬da. E’ vero che si costruisce in modo diverso in ogni paesi Europeo ed è innegabile che anche i risultati sono diversi a Berlino piuttosto che a Londra, Firenze o Barcellona. Ma d’altro canto non vorremmo neanche ignorare quelle differenze che costituiscono anche l’identità di ogni cultura europea, caratterizzata da fattori legati alla gestione del processo edilizio, ai costi di realizzazione ed alle tradizioni locali. Aspetti che sono spesso collegati.
Ad esempio, in Inghilterra è molto più costoso costruire rispetto ai costi a m2 che avete in Italia. Una differenza che non è imputabile ai costi della manodopera o dei materiali, ma ai costi del project management che in Inghilterra sono stratosferici. La figura stessa del project manager e di tutte le competenze correlate porta con sé un volume burocratico notevole. Tutto questo ha un costo che ancora non esiste in Italia.
Ci sono poi le condizioni climatiche e le tradizioni del costruire che sono diverse.
Così, per riuscire a realizzare un edificio che abbia la nostra firma, ma che sia capace di parlare anche la lingua del luogo dove viene eseguito, ci avvaliamo sempre di uno studio locale che non si limita ad ese-guire quanto noi progettiamo a Londra, ma in qualche misura lo ‘traduce’ e lo inserisce nel suo contesto. Ad esempio, a Taipei abbiamo realizzato una copertura con assi di 60 m in legno perché in quel luogo esiste una forte industria navale che ci ha consentito di avere le maestranze e la cultura costruttiva per farlo. Sarebbe assurdo progettare edifici come se non avessero un proprio genius loci. Così, il masterplan di Scandicci avrà una sua logica ‘locale’ anche se conterrà tutte le innovazioni che ci derivano dalla nostra visione ‘globale’ del mondo.
Rogers ha sempre sottolineato l’importanza di “cono¬scenze locali e visioni globali”, come approccio prope-deutico all’innovazione.
Modulo: L’emergenza climatica richiede che gli edifici del futuro siano sostenibili di “default”. Ma, lei crede nelle città ad emissioni zero?
Ivan Harbour: A Sidney stiamo realizzando un piano che riteniamo porti al massimo le potenzialità del costruire sostenibili in termini di riduzione del trasporto privato, di riciclo dell’acqua e di recupero del materiale di risulta. E’ un complesso polifunzionale con edifici per abitare, divertirsi e lavorare. Un mix funzionale che riduce la necessità di pendolarismo e quindi dell’uso di trasporto privato: un problema che incide ancora molto sui consumi energetici in Inghilterra dove si lavora in città ma si vive in campagna. Si tratta di un intervento modello dove stiamo applicando i più efficienti sistemi di recupero dell’acqua e di produzioni energetica da fonti rinnovabili. Ma non è solo una que¬stione di impianti, stiamo progettando il rivestimento delle residenze con grandi pannelli solari che cambiano aspetto in funzione del loro assorbimento solare. Una prestazionalità che renderà le facciate estremamente dinamiche e mutevoli durante l’arco della giornata.
Naturalmente parlare di emissioni zero rimane, comun¬que, un’affermazione ideologica perché dipende da quando cominci a valutare il consumo energetico. Se, ad esempio, cominci dalla produzione stessa dei materiali, non si potrà mai costruire ad emissioni zero.
Modulo: Guardando al futuro, cosa la preoccupa di più e cosa la rende più ottimista riguardo l’architettura?
Ivan Harbour: Guardo al futuro con ottimismo perché posso constatare la crescita di una sensibilità nuova nei confronti dell’emergenza energetica. Credo che la scarsità di risorse cambierà profondamente il modo in cui costruiamo e lo farà in meglio per lasciare ai nostri eredi un pianeta migliore. Con questo obbiettivo, lavoriamo per realizzare un ideale di tecnologia olistica, con cui interpretare i bisogni del futuro.
Ivan Harbour (partner di Richard Rogers): Il Centro Pompidou ed il Lloyd’s sono due manifesti dell’avanguardia che hanno trasformato il modo di fare architettura. La loro forza innovatrice ha però anche scioccato una certa parte di quella critica conservatrice che non ne condivideva né gli obbiet¬tivi nè i risultati. Per molti anni, lo stesso Movimento Moderno è stato giudicato con sospetto, fino quasi a rifiutarne le conquiste ideologiche. Gli anni ’90 sono stati anni difficili sia da un punto di vista economico che culturale. La recessione si è unita al primato culturale di un Establishment forte di un Governo Conservatore. Dal 1996, i Laburisti, guidati da Tony Blair, hanno consentito un dibattito che ha portato ad un rinnovamento. Così, durante l’amministrazione di Ken Livingston è stato possibile istituire una Urban Task Force, diretta da Rogers, che ha cominciato a sensibilizzare la politica e la gente comune su quanto l’architettura possa incidere sulla qualità urbana e, quindi, sulla qualità della vita di tutti.
Lo studio si è fortemente impegnato a promulgare l’etica della Modernità, aldilà della sua estetica. In questo senso, termini come High-Tech sono in effetti stati negativi perché comunicavano un’esasperazio-ne di certi aspetti del processo costruttivo che erano solo dei “mezzi”, il “fine” è sempre stata la qualità del vivere comune. Ma ci sono voluti anni di conferenze, mostre e pubblicazioni per arrivare oggi ad un clima culturale certamente più aperto e sensibile al valore dell’innovazione.
Nonostante questo, va ricordato che il 70% del nostro lavoro attuale è in corso di realizzazione fuori dai confini britannici.
Modulo: E’ passata una generazione dalla fonda¬zione dello studio, cosa è cambiato nella cultura del progetto e nella ricerca verso l’innovazione dagli anni ’70 ad oggi?
Ivan Harbour: Lo studio ha mantenuto una grande coerenza e continuità di pensiero. Concetti come onestà strutturale, leggibilità del processo costrutti¬vo, flessibilità, leggerezza, assemblaggio a secco dei componenti rimangono alla base del nostro linguaggio. Direi che quello che oggi è cambiato è la tipologia di edifici che affrontiamo. Abbiamo una gamma di complessi in corso che spaziano dai masterplan, agli uffici, ai centri culturali, fino alla residenza, alla scuola ed alla sanità. Siamo cioè in grado di dimostrare il valore civico dei nostri ideali.
Un esempio è Mossbourne Community Academy, la scuola che abbiamo realizzato nel borough di Hackney a Londra che il “Department for Education and Skills” ha giudicato come un modello da seguire per i prossi¬mi programmi didattici. In sanità, il Maggie’s Centre a Londra, è un edificio a piccola scala (170 m2) ma con grande attenzione ai dettagli ed alle finiture. Un piccolo edificio con un grande impatto umano che ha ricevuto lo Stirling Prize nel 2009. Questa trasversalità tipologica e la capacità di progettare dalla piccola alla grande scala caratterizza questo ultimo decennio; gli ideali del nostro studio non sono mai cambiati.
Modulo: Dal Pompidou ad oggi, quali sono state le più grandi conquiste dello studio?
Ivan Harbour: Molte sono state le sfide, ma quella che forse oggi è la più grande conquista è l’essere riusciti a consolidare uno spirito di squadra che ritengo sia la forza vincente dello studio. Il concetto di team work, cioè di massimo spirito collaborativo sono fondamentali per chi vuole lavorare con noi. Ogni lunedì, tutti i diver¬si gruppi che lavorano ad un progetto si riuniscono, dal capo progetto allo stagista, affinché vi sia condi¬visione delle tematiche da affrontare. Nessuno deve sentirsi un esecutore, ma partecipe di quello che sta facendo. Si discute di un progetto con lo spirito di un workshop, cioè con l’intento di sollevare i problemi più che di risolverli. Ci piace l’idea di celebrare la volontà di essere una comunità con la disponibilità verso le opi¬nioni altrui. Uno spirito comunitario che dimostriamo anche nel continuare ad essere una “charity”, cioè a devolvere il 20% del nostro fatturato in beneficenza.
Modulo: Gli studi internazionali più importanti stanno tutti affrontando il loro ‘passaggio generazionale’. Cambiare il nome dello studio da RRP a RSH+P è un evidente segno in questa direzione. Come state affrontando questo canbiamento?
Ivan Harbour: Ci sono molti modi di gestire il così detto passaggio generazionale. Norman Foster è oggi il consulente esterno del suo stesso studio, Nicholas Grimshaw ha scelto di diventarne il chairman. Richard Rogers passa la maggior parte della sua vita in studio e, come sempre, rimane pienamente protagonista di tutte le attività dello studio, ma è arrivato il momento in cui si è sentito il bisogno di “condividere il peso” della gestione delle responsabilità.
Sia Graham Stirk che io svolgiamo, a tutti gli effetti, lo stesso lavoro di prima, solo con maggior consapevolezza. D’altro canto, in termini di età, oggi io sono più giovane rispetto a quando Richard fondò lo studio e quindi vedo un futuro molto lontano, in cui evolvere e cambiare ancora.
Modulo: Da quando i Partners fondatori hanno lasciato il loro ruolo ufficiale, come si è riorganizzato lo studio?
Ivan Harbour: Ai tempi del Pompidou lo studio era composto da poco più di 30 persone, ora siamo oltre 180 nelle varie sedi internazionali. Questo ha richie¬sto un maggior numero di Direttori e responsabili dei vari settori, dall’amministrazione, alla progettazione, affinché non venga mai a mancare il controllo puntuale su ogni lavoro.
Modulo: Se dovesse “nominare” i progetti più simbolici del Terzo Millennio, quali menzionerebbe e perchè?
Ivan Harbour: L’aeroporto di Barajas a Madrid ed il Maggie’s Centre a Londra. Penso che per motivi diversi costituiscano due simboliche innovazioni. Barajas è stata un’esperienza unica che ha aggiornato molti temi identificativi della nostra architettura. Ad esempio l’utilizzo del colore che coadiuva la leggibilità della struttura dei componenti. A Madrid non è stato faci¬le, perché spesso le scelte cromatiche sono legate a connotazioni politiche. Per evitare messaggi di questo genere abbiamo quindi adottato una policromia che enfatizza esclusivamente il valore della composizione. La copertura è un incredibile virtuosismo tecnologico che utilizza il bambù, mai considerato prima per un aeroporto. Il Maggie è un grande successo perché ha dimostrato la capacità dello studio di gestire edifici di piccola scala ma, soprattutto, di saper dialogare con una committenza che non è di tipo aziendale. Siamo cioè riusciti ad interpretare i bisogni di una comunità eterogenea di persone che condividono una missione di solidarietà verso chi soffre.
Modulo: I committenti sembrano essere sempre più cauti con gli investimenti. Cosa si aspettano oggi che forse non chiedevano in passato?
Ivan Harbour: La crisi dei mercati e l’affermarsi delle economie competitive dei paesi emergenti ha avuto anche ricadute positive. Mi riferisco alla maggiore consapevolezza sul valore della qualità. Oggi la qualità dell’architettura si riflette sull’immagine corporativa dell’azienda molto più che in passato. Questo significa anche che la sostenibilità, intesa come benessere interno per gli utenti e riduzione dei costi di gestione, hanno un peso che non avevano in passato. Si è cioè indubbiamente consolidata una presa di coscienza verso un rispetto ed una salvaguardia per l’ambiente che non esisteva prima. In questa direzione, un edificio modello di questo cambiamento è la National Assem¬bly for Wales, anche se forse tutte le potenzialità di questo progetto non sono sfruttate a pieno.
Modulo: Lo studio opera a livello globale ed, oggi, sempre più in Europa: come si colloca la situazione Italiana nello scenario economico e culturale Europeo?
Ivan Harbour: E’ difficile rispondere a questa doman¬da. E’ vero che si costruisce in modo diverso in ogni paesi Europeo ed è innegabile che anche i risultati sono diversi a Berlino piuttosto che a Londra, Firenze o Barcellona. Ma d’altro canto non vorremmo neanche ignorare quelle differenze che costituiscono anche l’identità di ogni cultura europea, caratterizzata da fattori legati alla gestione del processo edilizio, ai costi di realizzazione ed alle tradizioni locali. Aspetti che sono spesso collegati.
Ad esempio, in Inghilterra è molto più costoso costruire rispetto ai costi a m2 che avete in Italia. Una differenza che non è imputabile ai costi della manodopera o dei materiali, ma ai costi del project management che in Inghilterra sono stratosferici. La figura stessa del project manager e di tutte le competenze correlate porta con sé un volume burocratico notevole. Tutto questo ha un costo che ancora non esiste in Italia.
Ci sono poi le condizioni climatiche e le tradizioni del costruire che sono diverse.
Così, per riuscire a realizzare un edificio che abbia la nostra firma, ma che sia capace di parlare anche la lingua del luogo dove viene eseguito, ci avvaliamo sempre di uno studio locale che non si limita ad ese-guire quanto noi progettiamo a Londra, ma in qualche misura lo ‘traduce’ e lo inserisce nel suo contesto. Ad esempio, a Taipei abbiamo realizzato una copertura con assi di 60 m in legno perché in quel luogo esiste una forte industria navale che ci ha consentito di avere le maestranze e la cultura costruttiva per farlo. Sarebbe assurdo progettare edifici come se non avessero un proprio genius loci. Così, il masterplan di Scandicci avrà una sua logica ‘locale’ anche se conterrà tutte le innovazioni che ci derivano dalla nostra visione ‘globale’ del mondo.
Rogers ha sempre sottolineato l’importanza di “cono¬scenze locali e visioni globali”, come approccio prope-deutico all’innovazione.
Modulo: L’emergenza climatica richiede che gli edifici del futuro siano sostenibili di “default”. Ma, lei crede nelle città ad emissioni zero?
Ivan Harbour: A Sidney stiamo realizzando un piano che riteniamo porti al massimo le potenzialità del costruire sostenibili in termini di riduzione del trasporto privato, di riciclo dell’acqua e di recupero del materiale di risulta. E’ un complesso polifunzionale con edifici per abitare, divertirsi e lavorare. Un mix funzionale che riduce la necessità di pendolarismo e quindi dell’uso di trasporto privato: un problema che incide ancora molto sui consumi energetici in Inghilterra dove si lavora in città ma si vive in campagna. Si tratta di un intervento modello dove stiamo applicando i più efficienti sistemi di recupero dell’acqua e di produzioni energetica da fonti rinnovabili. Ma non è solo una que¬stione di impianti, stiamo progettando il rivestimento delle residenze con grandi pannelli solari che cambiano aspetto in funzione del loro assorbimento solare. Una prestazionalità che renderà le facciate estremamente dinamiche e mutevoli durante l’arco della giornata.
Naturalmente parlare di emissioni zero rimane, comun¬que, un’affermazione ideologica perché dipende da quando cominci a valutare il consumo energetico. Se, ad esempio, cominci dalla produzione stessa dei materiali, non si potrà mai costruire ad emissioni zero.
Modulo: Guardando al futuro, cosa la preoccupa di più e cosa la rende più ottimista riguardo l’architettura?
Ivan Harbour: Guardo al futuro con ottimismo perché posso constatare la crescita di una sensibilità nuova nei confronti dell’emergenza energetica. Credo che la scarsità di risorse cambierà profondamente il modo in cui costruiamo e lo farà in meglio per lasciare ai nostri eredi un pianeta migliore. Con questo obbiettivo, lavoriamo per realizzare un ideale di tecnologia olistica, con cui interpretare i bisogni del futuro.
Vai alla scheda dello studio di progettazione: ROGERS STIRK HARBOUR + PARTNERS